di Antonio Brusa
I castelli sono dei mitomotori così naturali, che già in un passato lontano furono sottratti alla storia e trasferiti nel mondo delle fiabe, dove venivano adibiti di solito alla custodia di principesse in lacrime, alla cui sicurezza badavano draghi per lo più sputafuoco. Chiedete a un bambino di disegnare un castello. Molto probabilmente non riprodurrà le fattezze rotondeggianti di quello di Taranto, o gli spigoli dei bastioni di Bari o Barletta, ma nei suoi disegni svetteranno guglie e agili torrette, come nel castello fintomedievale di Neuschwanstein, che piacque così tanto a Walt Disney che ne fece il modello per i suoi cartoni animati e i suoi parchi a tema.
 Fig.1: 1 Il castello di Neuschwanstein, costruito da Ludovico II di Baviera alla fine del 1800 FonteDalle fiabe agli anime giapponesi, alla grande fiction internazionale, ai giochi e ai videogiochi il passo è stato breve, anch’esso quasi spontaneo. E, anche in questa transizione, i modelli reali non hanno contato granché. Se il castello è un rudere, luogo prediletto da personaggi sovente malvagi, circondati da una guardia di corvi e avvoltoi, non assomiglierà a quello di Gravina né riprodurrà i pochi resti di Castel Fiorentino, dove pure Federico II emise i suoi ultimi sospiri, ma sarà inerpicato su una roccia inaccessibile e, se a qualcuno verrà in mente il profilo del Garagnone, dovrà subito ricredersi di fronte al fiume di lava che, non di rado, circonda la costruzione diabolica. Se il castello è ancora ben conservato, sembra andar meglio per gli affezionati alla storia, perché può darsi che il regista ceda al fascino della realtà, dimostrando che questa non è meno attraente della fantasia. Lo vediamo nella meticolosa riproduzione della Cittadella di Acri, in Assassin Creed, nella Rocca Calascio, in Abruzzo, usata per il nome della Rosa (ma con chiari rimandi a Castel del Monte), o nei numerosi castelli che hanno fatto da sfondo al viaggio dell’Armata Brancaleone, per lo più dell’Italia centrale: ma l’ultimo, il definitivo, è quello di Isola Capo Rizzuto, in Calabria: Germana Gandino ha individuato con gusto e pazienza certosina tutte le location del film, in un articolo che ci consegna sempre il piacere della lettura.
Fig.1: 1 Il castello di Neuschwanstein, costruito da Ludovico II di Baviera alla fine del 1800 FonteDalle fiabe agli anime giapponesi, alla grande fiction internazionale, ai giochi e ai videogiochi il passo è stato breve, anch’esso quasi spontaneo. E, anche in questa transizione, i modelli reali non hanno contato granché. Se il castello è un rudere, luogo prediletto da personaggi sovente malvagi, circondati da una guardia di corvi e avvoltoi, non assomiglierà a quello di Gravina né riprodurrà i pochi resti di Castel Fiorentino, dove pure Federico II emise i suoi ultimi sospiri, ma sarà inerpicato su una roccia inaccessibile e, se a qualcuno verrà in mente il profilo del Garagnone, dovrà subito ricredersi di fronte al fiume di lava che, non di rado, circonda la costruzione diabolica. Se il castello è ancora ben conservato, sembra andar meglio per gli affezionati alla storia, perché può darsi che il regista ceda al fascino della realtà, dimostrando che questa non è meno attraente della fantasia. Lo vediamo nella meticolosa riproduzione della Cittadella di Acri, in Assassin Creed, nella Rocca Calascio, in Abruzzo, usata per il nome della Rosa (ma con chiari rimandi a Castel del Monte), o nei numerosi castelli che hanno fatto da sfondo al viaggio dell’Armata Brancaleone, per lo più dell’Italia centrale: ma l’ultimo, il definitivo, è quello di Isola Capo Rizzuto, in Calabria: Germana Gandino ha individuato con gusto e pazienza certosina tutte le location del film, in un articolo che ci consegna sempre il piacere della lettura.
 Fig.2: Il Garagnone imbiancato. Descritto magnificamente in una tesi di Paola Miglietta, con la guida di Franco Porsia a Uniba. I molti fantasmi dei castelli pugliesi
Fig.2: Il Garagnone imbiancato. Descritto magnificamente in una tesi di Paola Miglietta, con la guida di Franco Porsia a Uniba. I molti fantasmi dei castelli pugliesi
Dal canto loro, i castelli – quelli reali - hanno ospitato sempre volentieri storie meravigliose. In particolare, quelle dei fantasmi. Tuttavia, per vivere l’emozione dell’oltretomba non è necessario recarsi nelle colline brumose di Scozia, dove le anime vagano suonando la cornamusa e lamentandosi per le tante sconfitte che illustrano la storia di quella terra. Anche i castelli pugliesi hanno i loro pallidi abitatori. Abitatrici, dovremmo dire piuttosto, dal momento che si tratta di nobildonne sventurate, rinchiuse da mariti gelosi, come a Sannicandro di Bari, Trani, Pulsano sul Gargano o a Monopoli, dove la fantasma suona il tamburo e invita le ragazze a guardarsi da relazioni sentimentali che possono condurre a esiti infausti, come la sua triste vicenda confermerebbe. Non manca una principessa come Bianca Lancia, la bella ragazza piemontese, amante di Federico II, al quale dette il futuro erede Manfredi, e che il sovrano (gelosissimo, nonostante il conforto dei suoi harem) rinchiuse in un castello.
 Fig.3: Impronta miracolosa del seno di Bianca Lancia, un punto a favore del castello di Gioia del Colle Fonte Quale? E qui sarete obbligati a scegliere fra Monte sant’Angelo e Gioia del Colle, per quanto questo vanti l’impronta del seno che la poverina incise miracolosamente sulla parete, prima di suicidarsi. Ma se non riuscirete a decidervi, allora potrete chiamare in causa i poteri ubiquitari dei fantasmi che, come sappiamo, permettono loro di infestare due luoghi contemporaneamente. In questa dolente compagnia di fanciulle, un’eccezione c’è, e la trovate in Castel Pagano, le cui rovine si stagliano su uno spunzone di roccia nei pressi di Apricena. Qui la storia-favola racconta di un principe saraceno che si innamorò di una bella figliola cristiana, cosa che - essendo ai tempi poco salubre - ridusse rapidamente, anche lui, alla natura di fantasma.
Fig.3: Impronta miracolosa del seno di Bianca Lancia, un punto a favore del castello di Gioia del Colle Fonte Quale? E qui sarete obbligati a scegliere fra Monte sant’Angelo e Gioia del Colle, per quanto questo vanti l’impronta del seno che la poverina incise miracolosamente sulla parete, prima di suicidarsi. Ma se non riuscirete a decidervi, allora potrete chiamare in causa i poteri ubiquitari dei fantasmi che, come sappiamo, permettono loro di infestare due luoghi contemporaneamente. In questa dolente compagnia di fanciulle, un’eccezione c’è, e la trovate in Castel Pagano, le cui rovine si stagliano su uno spunzone di roccia nei pressi di Apricena. Qui la storia-favola racconta di un principe saraceno che si innamorò di una bella figliola cristiana, cosa che - essendo ai tempi poco salubre - ridusse rapidamente, anche lui, alla natura di fantasma.
I tre stereotipi fondamentali dei castelli
Un tempo queste storie si raccontavano ai bambini nella convinzione che avrebbero dormito sereni, o si leggevano in qualche romanzo strappalacrime. Oggi viaggiano su internet, attraverso i siti turistici e dei sempre più numerosi seguaci di Dylan Dog. Internet, dal canto suo, è diventata il veicolo d’elezione di un’altra classe di storie fantastiche sui castelli: gli stereotipi. Questi si differenziano dalle storie di fantasmi perché si presentano come vere (non me ne vogliano gli indagatori dell’occulto). Anzi, incrollabilmente vere, come suggerisce la stessa parola – stereotipo - che allude al fatto che si tratta di conoscenze stampate nel cervello e, quindi, difficilmente estirpabili.
Gli stereotipi amano molto i castelli e internet lo dimostra. Infatti, se cliccate “castelli medievali”, non appena avrete superato la prima barriera di citazioni da “Focus” e Wikipedia (che ultimamente si sono meritoriamente aggiornate), vi perderete nell’oceano delle oltre 900 mila occorrenze in rapida crescita (si sono raddoppiate in appena dieci anni) dove si scopre il fatto – poco consolante per gli studiosi, ma non so dire per quanti altri - che gli stereotipi hanno avuto di gran lunga la meglio sulle conoscenze storiche. Questi stereotipi riguardano, in particolare, alcuni aspetti della questione dei castelli.
La forma del castello è il primo stereotipo. Abbiamo già visto che l’immagine disneyana ha molto successo presso i bambini. Per tutti gli altri (adulti compresi) l’immagine vincente è quella del castello quattro-cinquecentesco. Magari secentesco. Quello con bastioni, torrioni, ponti levatoi e un bel fossato, il tutto progettato secondo i dettami della scienza rinascimentale e barocca delle fortificazioni. Quello, in fondo, che possiamo riconoscere in molti castelli pugliesi il cui look è frutto di così tanti aggiustamenti, che solo un occhio esperto riesce a riconoscere i tratti medievali.
Un recinto, con una torre, una casa nobiliare e un pugno di capanne: è così che dovremmo immaginare molti nostri castelli. Comprendiamo, perciò, la delusione per gli imprenditori di marketing territoriale e degli assessori all’identità culturale (questi ultimi, bisogna riconoscerlo, allignano più volentieri nelle regioni settentrionali che in Puglia).
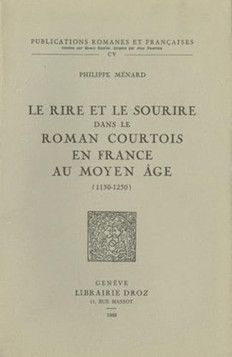 Il secondo stereotipo più diffuso riguarda la vita che si conduceva dentro i castelli, che si immagina caratterizzata dai sollazzi che il signore si concedeva, fra mangiate pantagrueliche, rigorosamente con le mani (particolare irresistibile per gli studenti), con un commento sonoro fatto di grasse risate: d’altra parte, non fu Philippe Ménard che sostenne che nel medioevo non si sorrideva, ma si sghignazzava? Traeva questa convinzione dai poemi che i trovatori cantavano per allietare questa rumorosa compagnia.
Il secondo stereotipo più diffuso riguarda la vita che si conduceva dentro i castelli, che si immagina caratterizzata dai sollazzi che il signore si concedeva, fra mangiate pantagrueliche, rigorosamente con le mani (particolare irresistibile per gli studenti), con un commento sonoro fatto di grasse risate: d’altra parte, non fu Philippe Ménard che sostenne che nel medioevo non si sorrideva, ma si sghignazzava? Traeva questa convinzione dai poemi che i trovatori cantavano per allietare questa rumorosa compagnia.
Il terzo stereotipo è straordinariamente importante, a dispetto del fatto che può sembrare un vezzo di eruditi. Lo potremmo definire quello della “monofunzionalità dei castelli”. A che serve un castello? A difendersi, uno direbbe subito, soggiungendo dottamente che, per farlo bene, versavano olio bollente dalle caditorie (altro stereotipo indistruttibile, che ho ascoltato persino dalle guide dei castelli estoni, dove chissà se mai si assaggiò un olio d’oliva bono et claro, quale troviamo nelle fonti pugliesi). Oppure, no, direbbe un altro: per svago e per caccia. E, dunque, dai a classificare: questo castello serve per la caccia, quest’altro per la difesa o per il controllo del territorio, e quest’altro per proteggere le derrate alimentari. Affanni del tutto inutili, e curiosità fatue quando, di fronte a Castel del Monte o al Castello di Terra di Brindisi, ci si pone la fatidica domanda: “a che cosa serviva?”. I castelli, come ci hanno insegnato in tanti, da Aldo Settia all’indimenticabile Raffaele Licinio, sono costruzioni multifunzionali. Servivano a tante cose. I signori e i sovrani, che spendevano buona parte delle loro ricchezze per tirarli su e aggiornarli (i castelli richiedono ancora oggi una manutenzione costosa), cercavano di trarne il massimo profitto: e, dunque, all’occorrenza vi stipavano risorse alimentari o armi, vi alloggiavano guarnigioni, allestivano difese o attacchi e, fra una guerra e l’altra, un’assemblea politica e un’altra, vi andavano a caccia.
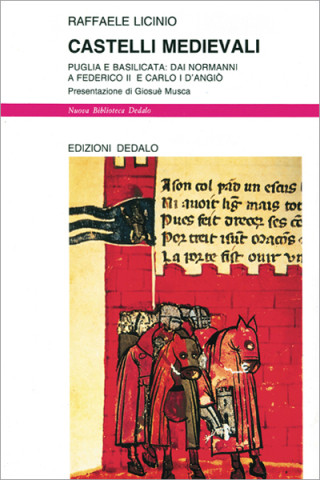 Lo stereotipo supremo: il castello svevo
Lo stereotipo supremo: il castello svevo
Questi stereotipi “infestano” tutti i castelli europei. Ma ce ne è uno che è tipicamente pugliese. Lo stereotipo svevo. Ogni città pugliese sogna che il proprio castello abbia visto la luce in quei pochi decenni nei quali regnò Federico II. Poco importa se la costruzione abbia ascendenze normanne o perfino arabe, angioine, aragonesi. L’importante è che sia definito “svevo”. In purezza o, alla men peggio, col trattino. Sono pochi i castelli che dichiarano onestamente di essere aragonesi, come quello di Taranto, o fondati da Carlo V, e dunque “moderni”, come quelli di Lecce o di Monopoli.
Eppure, anche in questo caso, la lezione di Raffaele Licinio dovrebbe essere definitiva. Federico II costruì con sicurezza due castelli in Puglia: Castel del Monte e quello di Gravina. Poi ne restaurò altri (certo, come tutti i suoi colleghi, si vantava di “averli costruiti”), ma se contiamo le fortificazioni che lo svevo atterrò – proseguiva con qualche ironia Licinio – più che costruttore, lo dovremmo definire “distruttore di castelli”.
L’ossessione sveva è, però, un qualcosa che travalica il marketing territoriale, perché è connessa con quella precisa attività politica che ha cercato, nel secolo scorso, di costruire l’identità pugliese. Dove trovare il nucleo originario di questa identità? Nel Neolitico, che vanta realtà archeologiche celebri, ma - ahimè - solo fra gli studiosi? Oppure nel mondo magnogreco, straordinario ma riguardante principalmente il versante ionico? La fama del Castel Del Monte, al quale il restauro di fine ottocento aveva dato la forma che attualmente ammiriamo e, conseguentemente, quella dell’imperatore svevo, l’ebbe vinta. E poi, non è forse vero che questi fu appellato “puer apuliae”? Ora, poco importa che lo svevo soggiornò in Puglia come in altre regioni che potrebbero ambire con ugual titolo alla “svevità”, e che quel soprannome fu coniato in segno di spregio (come se lo avessero ingiuriato: “terrone” …), il fatto è che Federico II è diventato il brand pugliese, presente nello stemma della regione (l’ottagono), in innumerevoli festival e iniziative culturali, oltre che in una quantità industriale di prodotti, agricoli e no.
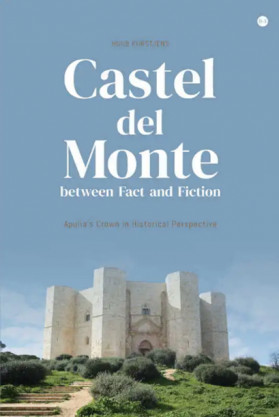
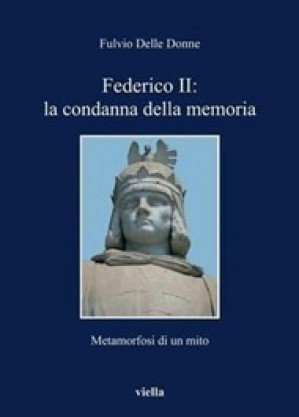
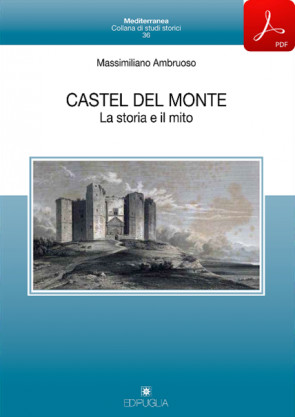 Castel del Monte, il mitofantasma
Castel del Monte, il mitofantasma
Questi fatti - dalle favole alle politiche identitarie - non sono tipici della Puglia. Li ritroviamo, in forme più o meno evidenti, in tutta Europa. Ma in Puglia c’è un qualcosa di unico. Castel del Monte. Incomparabile non per la sua bellezza o il fascino indubbio che emana (castelli belli ce ne sono al mondo, suvvia), ma per il fatto che attira su di sé favole, stereotipi e politiche identitarie in tale quantità che Huub Kurstjiens, uno studioso di Nimega, amante come pochi delle cose pugliesi, ha scritto che questo castello non è un mitomotore come tanti, ma un originalissimo “mitofantasma”. Un oggetto che intrattiene rapporti “più con la fantasia che con i documenti storici”.
È uno dei luoghi deputati alla custodia del santo Graal e, in mancanza di questo, di un tesoro purchessia, che alla fine della Seconda guerra mondiale venne cercato veramente dai reparti tedeschi in ritirata, fra un sabotaggio e una fucilazione; è situato lungo l’asse magico che unisce Mont Saint Michel col Tempio di Salomone a Gerusalemme; ha degli orientamenti speciali con le stelle che ne fanno un calendario, un luogo magico, uno scrigno esoterico; un luogo di culto templare, con fontane dove ci si purificava (o dove Federico violentava delle vergini incaute). Vi si facevano feste, no, non vi si poteva cucinare, perché il cibo veniva portato da altrove (primo esempio mondiale di catering?). Vi erano soldati, no, i soldati non vi potevano alloggiare. Era un gigantesco hammam, alimentato da cisterne sotterranee, anzi no, pensili, capolavoro dell’architettura mondiale al pari dei giardini pensili, altrettanto inventati, di Babilonia. Si trovano, sul suo terrazzo delle scritte stranissime, che certamente alludono a qualcosa di demoniaco.
Se ne ho dimenticata qualcuna di queste trovate, è perché non ho la pazienza di Massimiliano Ambruoso che le ha raccolte tutte con le rispettive confutazioni, in un libro la cui lettura è inderogabile per chi voglia ammirare il castello per quello che è. Ma se non vi va di leggerlo, vi basta porgere l’orecchio a qualche guida che, ancora oggi, pensa che queste invenzioni siano un buon atout da giocarsi con turisti affamati di stranezze medievali. Storie che circolano e alla grande, nonostante le smentite di molti medievisti, come Licinio, che avvertiva tutti di stare attenti alle misure geometrico-astrali del castello, visto che la forma attuale è stata alterata dal restauro di fine Ottocento, o di Franco Magistrale, che lesse quelle scritte diaboliche e le ricondusse alla prosaica firma di un mastro di Andria del Cinquecento, che avendo restaurato la copertura del castello, ne lasciava il ricordo a imperitura memoria e, anche se non gli passò per la testa, come alimento del medievalismo del XXI secolo.
La fantasia, però, fa parte del castello (e di Federico II)
Il “medievalismo”, infatti, è la categoria nella quale possiamo catalogare tutte queste storie. Ce l’ha spiegata magnificamente Tommaso di Carpegna Falconieri (qui trovate tutta la sua bibliografia http://www.tommasodicarpegna.it/ ). Sulla scorta delle sue lezioni, possiamo pensare che proprio “quello che si dice” di Castel del Monte è un oggetto storico di per sé affascinante da indagare. Un oggetto, per di più, che lo apparenta strettamente al suo costruttore. Anche Federico II fu circondato da tante storie, a volte promosse da lui stesso, a volte elaborate e diffuse da sostenitori e nemici, così numerose, divertenti o fantastiche, che la loro massa è diventata, di per sé, un oggetto di studi. La memoria di Federico è sia la sua condanna, come ha scritto Fulvio delle Donne, sia il filtro ineludibile attraverso il quale oggi ci avviciniamo a quel personaggio e che ci avverte, ancora prima di incontrarlo, della sua eccezionalità.
Allo stesso modo, l’alone delle storie è ormai inseparabile dal suo castello. E se ci interroghiamo sul perché questo sia diventato un tale mitofantasma, saremo forse costretti a spiegare questo fenomeno con il tentativo dei poveri umani di elaborare una meraviglia che ci appare indicibile.
* Ripubblico con diverse modifiche il mio articolo comparso nel volume Castelli di Puglia, dossier di “Repubblica” del 23 novembre 2024, curato da Domenico Castellaneta.