di Antonio Brusa
“L’appello lanciato questa estate da militanti “antirazzisti” in molti paesi democratici ad abbattere le statue di coloro che sarebbero più o meno direttamente legati alla tratta atlantica ha rimesso al centro del dibattito pubblico la questione della schiavitù. Al posto di migliorare la nostra conoscenza del carattere abietto del commercio degli schiavi neri nella pluralità delle sue manifestazioni geografiche, la frenesia vendicatrice alla quale stiamo assistendo non ha fatto altro che rinforzare l’idea, peraltro già ben radicata, secondo la quale non ci fu che una sola Tratta dei Neri: quella condotta dagli Occidentali fra i secoli XV e XIX”.
Con queste parole, Matthieu Creson apre il suo articolo sulla “persistenza del tabù della Tratta”, appena pubblicato dall’autorevole “Revue des deux Mondes” (7 sett. 2020). Nell’immaginario italiano ci vediamo lontani spettatori di questa vergogna storica. Pensiamo che siano fatti che riguardano gli stati atlantici, europei e americani, ben lontani da noi mediterranei. Le cose non stanno in questo modo. Per due motivi. Il primo è che il fenomeno della schiavitù riguardò direttamente l’Italia fino a tutta l’età moderna, come ci ha insegnato Salvatore Bono (Schiavi. Una storia mediterranea. XVI-XIX secolo, Il Mulino, Bologna: qui il riassunto analitico). Il secondo è che la polemica contro la schiavitù mette sul banco degli imputati l’intero occidente, europei e italiani compresi.
Per tutti quelli che si occupano di storia, infine, questo è un magnifico, quanto penoso, caso di studio sui rapporti fra la memoria storica, alla quale fanno riferimento i movimenti di protesta, e la ricerca storica.
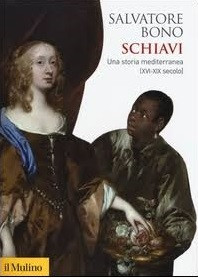
I motivi che hanno scatenato le proteste sono indiscutibili. Non possono che suscitare indignazione in tutto il mondo il razzismo e le ingiustizie sociali che spingono nelle strade tanti cittadini americani. Ciò che Matthieu Creson sottolinea è il discorso storico che accompagna e alimenta molta parte del movimento. Questo discorso è viziato da due rimozioni. La prima è geografica: si rimuove il fatto che la Tratta atlantica non fu l’unica esistente. La seconda è storica: si rimuove il fatto che i primi stati a proclamare illegale lo schiavismo furono europei. Queste due rimozioni cementano due tabù, apparentemente incontrastati in quello che rischia di diventare un processo mondiale all’Europa: “non si può parlare di Tratte che non siano quella atlantica” e “non si può dire bene dell’Europa”.
La rimozione geografica
Il primo a farne un oggetto di dibattito pubblico è stato Olivier Petré-Grenouilleau, con il suo La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale(Il Mulino, Bologna 2010: vedine un buon riassunto qui)
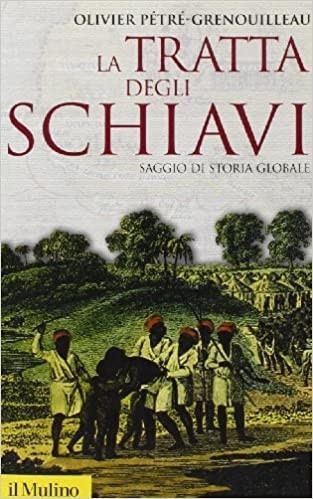
Lo storico francese scriveva che se si allarga lo sguardo al di là dello scenario atlantico, spuntano altre due tratte, altrettanto dolorose di quella atlantica. La Tratta musulmana, che prelevava schiavi dall’Africa sub-sahariana per venderli ai paesi mediterranei ed esportarli fino in Estremo oriente; e quella africana, della produzione e del consumo interno degli schiavi. I dati offerti dallo storico lasciavano senza fiato chi si avvicinava per la prima volta a questo problema. Se la tratta atlantica trasferì in America poco meno di 12 milioni di persone, quella interna africana ne riguardò 14 milioni e quella musulmana 19. Indubbiamente, questi dati erano da ponderare tenendo conto di due fattori. Il primo è che la tratta atlantica durò poco più di tre secoli, mentre il periodo preso in considerazione dallo storico per quelle islamica e africana andava dal 620 d. C al 1920. Il secondo è che, mentre per la tratta atlantica le fonti sono numerose e precise (i libri contabili dei negrieri, i contratti di vendita americani ecc.), non altrettanto si può dire delle altre due tratte che devono fare affidamento a stime, che secondo lo stesso Grenouilleau hanno un largo margine di variabilità. Altri storici, infatti, danno cifre diverse, che – tuttavia - essendo sempre dell’ordine dei milioni, non intaccano la sensazione di enormità del commercio islamico e africano.
(Lo storico francese non si occupava del commercio mediterraneo, i cui dati avrebbero aggiunto peso al terribile quadro della schiavitù mondiale, con i milioni di cristiani, fatti schiavi dai corsari barbareschi, e i milioni di nord-africani fatti schiavi dai cristiani (italiani e maltesi soprattutto), e venduti nei mercati di Livorno, Napoli, Genova e Palermo, insieme con quelli dell’Africa nera che pure giungevano in Italia).
Shitstorm mediatico
Quando uscì in Francia, nel 2005, il libro di Grenouilleau divise il pubblico. Fu esaltato come opera fondamentale da molti storici, dall’Académie e dal Senato (che pure aveva proclamato, con la legge Taubira del 2001, che lo schiavismo è un crimine contro l’umanità). Dall’altra suscitò vive proteste da parte delle comunità afro-francesi e antillane, che accusarono lo storico di “negrofobia”, chiesero che venisse processato, proprio per la violazione della legge Taubira, e lo sottoposero a un indegno shitstorm mediatico, con insulti e accuse di ogni genere, delle quali la rete, a dispetto del mito della sua memoria indistruttibile, conserva tracce scarse e difficili da reperire (qui una cronologia degli interventi, un tempo ben in vista, oggi quasi introvabili. Noterò ancora che l’articolo di Clionautes, che citavo a questo proposito nel 2016, è sparito).
I fabbricanti di schiavi
I mercanti occidentali acquistavano gli schiavi nei mercati africani: quelli atlantici, oggi meta del turismo memoriale (ne scrive Elisa Magnani), e quelli indiani, altrettanto celebri, come Zanzibar. Quest’isola era anche un centro di smistamento della tratta islamica, al pari di Timbuctù, dove si concentravano le carovane di schiavi destinate ai mercati della costa nordafricana. Ma come venivano prodotti questi schiavi? Ne sappiamo poco, scrive John Iliffe. A metà Ottocento, un missionario chiese a 177 schiavi liberati in che modo erano stati fatti schiavi. Un terzo dichiarò che era prigioniero di guerra; un altro terzo che si trovava già in condizioni di schiavitù quando fu portato al mercato. Altri erano stati fatti schiavi per debiti; un paio perché erano figli di donne accusate di stregoneria. Come sapevano – e scrivevano – i negrieri, la prospettiva di un buon guadagno incentivava i tribunali africani a comminare la pena della schiavitù per una gran quantità di reati. Al di là di particolari e di cifre che vanno ancora messi in piena luce, ciò che sappiamo è che dietro le Tratte atlantica e islamica agì un sistema schiavistico consolidato nel tempo, interamente africano, fatto di imperi, regni e individui che lucravano sulla riduzione in schiavitù di uomini e donne nere, che evidentemente non consideravano “fratelli” (J. Iliffe, Popoli dell’Africa. Storia di un continente, Bruno Mondadori, Milano 2007, p. 179).
Vittime e carnefici
“La maggior parte degli studi recenti, di qualsiasi scuola, concludeva Grenouilleau, ci dice che gli africani non furono solamente vittime della tratta, ma anche artefici” (p. 187). Lo storico avrebbe potuto richiamarsi con efficacia alla formula icastica - “nessun popolo è vergine”- che Franco Cassano ha inciso nel suo libro più bello (Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro, Il Mulino, Bologna 2003). Il ruolo della vittima e del carnefice si sono alternati più volte nei tempi lunghissimi dei diversi gruppi umani. Una storia che ne selezioni solo alcuni aspetti impedisce di fare i conti con i passati vergognosi di ciascuno. Rischia, in luogo di creare una società che si riconosce unita nella condanna del crimine della schiavitù, di lacerarla con un desiderio di vendetta, che è un temibile motore dell’alternanza fra vittima e persecutore. Nel pieno della polemica sul suo libro, Grenouilleau scriveva: “È importante comprendere che gli Occidentali, gli Orientali o gli Africani odierni non sono affatto responsabili dei crimini commessi da qualcuno dei loro antenati, e che non serve a niente aizzare le comunità, le une contro le altre. Come scriveva Edouard Glissant a proposito della schiavitù, il lavoro della memoria non deve far rivivere il passato. A noi serve una “memoria che sa andare oltre” (Traite négrière : les détournements de l'histoire, par Olivier Petre-Grenouilleau, in “Le Monde”, 5 marzo 2005).
La rimozione storica
Se la schiavitù è un fenomeno che interessò la stragrande maggioranza dei gruppi umani (forse solo gli indigeni australiani ne furono esenti), la sua abolizione è un evento che riguarda esclusivamente l’Europa. In moltissime società esistettero filosofi, poeti e governanti che hanno manifestato la loro avversione per questo istituto. Ma solo in Europa questa ostilità si è concretizzata nella sua messa fuori legge. Questo evento dovrebbe essere celebrato come identitario di una umanità, come quella attuale, che si proclama antirazzista e antischiavista. Non è dunque paradossale il fatto – si chiede Pascal Bruckner - “che le prime società che hanno abolito la schiavitù, dopo averne largamente approfittato, siano le sole ad essere messe sotto accusa, le sole alle quali si chiede una riparazione?” (La tyrannie de la pénitence. Essai sur le masochisme occidentale, Grasset, Parigi 2006, p. 174).
Il doppio versante della rimozione
La questione dello schiavismo, per come viene affrontata nei movimenti di protesta mondiali, diventa un tutt’uno con quella del colonialismo europeo, con il conseguente bilancio post-coloniale e con il razzismo. L’evento dell’abolizione, quindi, viene seppellito sotto un cumulo di misfatti che preme anche sul versante interno all’Occidente, incrementando quel sentimento di “autocolpevolizzazione” che caratterizza il rapporto che Europa e Occidente intrattengono con il loro passato, e producendo, di conseguenza, una memoria unidirezionale. Perché è una strana “memoria della schiavitù quella che impone solo all’Occidente di fare penitenza e di risarcire i discendenti degli schiavi” (Creson, cit.).
Fernando Duarte ha provato a quantificare l’ammontare di questi risarcimenti. Secondo gli stati africani si tratterebbe di 777 miliardi di dollari (dati del 1999); mentre i trenta milioni di discendenti americani di schiavi africani avrebbero diritto a una compensazione di 250 mila dollari a testa (Réparation de l'esclavage : les descendants d'esclaves doivent-ils recevoir une compensation financière? 2 luglio 2020). Tuttavia, per quanto lo storico non debba trascurare gli aspetti economici nella sua analisi, sarebbe sbagliato farne una questione di soldi. Ce lo fa capire la delibera di professori e studenti del Dipartimento di Letteratura inglese dell’Università di Chicago, approvata dopo l’assassinio di George Floyd, nel luglio del 2020. Vi si stabilisce che per l’anno accademico 2020-2021 verranno accolti solo studenti neri o che si impegneranno nei Black Studies, la branca delle discipline umanistiche che il dipartimento si propone di sviluppare. È un debito, proseguono i colleghi americani, che la collettività degli studiosi deve pagare, perché “la letteratura inglese, come disciplina, nella sua lunga storia ha ammantato di una razionalizzazione estetica la colonizzazione, lo sfruttamento, l’estrazione dei neri, e l’anti-negritudine (anti-blackness)” e che, quindi, il loro dovere di studiosi è quello di “eliminare l’anti-negritudine persistente e recalcitrante della nostra disciplina”.
Due documenti per comprendere una rivoluzione
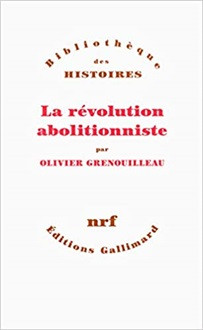
 Am I Not a Man and a Brother?, il medaglione disegnato da Josiah Wedgwood nel 1787 contro la schiavitù (Fonte)
Am I Not a Man and a Brother?, il medaglione disegnato da Josiah Wedgwood nel 1787 contro la schiavitù (Fonte)
Si diceva nelle buone famiglie di un tempo che una dote di matrimonio non era adeguata se non avesse compreso qualche ceramica Wedgwood. Josiah Wedgwood era un imprenditore, inventore e designer di ceramiche adorate dalle famiglie borghesi. Era anche amico e fervido sostenitore di Thomas Clarkson, il primo storico del movimento abolizionista. Questo medaglione, autentico logo del movimento, fu regalato a Benjamin Franklin, presidente della società abolizionista della Pennsylvania. Diventò un gioiello esibito dalle signore di tutt’Europa. Più efficace di un libro, commentò Franklin.
Osservato con gli occhi moderni, quest’uomo nero e incatenato, che supplica di essere considerato un fratello, è lo stigma del “nero inferiore” che spinge il movimento di protesta ad abbattere i monumenti nei quali “un uomo bianco concede la libertà a schiavi neri che ringraziano” (su questo tema si veda l’articolo di Daniele Boschi, qui su Historia Ludens). Osservata con gli occhi di un individuo del XVIII secolo, invece, quest’immagine è rivoluzionaria, perché rompe con la tradizione più “inclusiva” che il mondo antico aveva consegnato alla modernità, quella delle religioni del libro, secondo le quali “non è lecito fare schiavo il fratello”. In base a questa norma, un cristiano (come un musulmano o un ebreo) non poteva ridurre in schiavitù un correligionario, proprio perché la comune fede li rendeva fratelli, ma poteva fare schiavi tutti gli altri. Il medaglione diceva alla gente del XVIII secolo che si è fratelli per il semplice fatto di essere uomini. Una rivoluzione, scrive Olivier Grenouilleau (La révolution abolitionniste,Gallimard, Paris 2017).
Con un salto di qualche anno, ci troviamo a Napoli, dove Antonio Savarese, medico “dei Reali Eserciti”, uno studioso che viaggiò in lungo e in largo, anche al seguito delle truppe napoleoniche, scrive testi di antropologia fisica e medicina. Letti con gli occhi moderni, sono libri insopportabilmente razzisti. Ci raccontano che i creoli sono un miscuglio indecente di razze e che i bianchi si sono degenerati al loro contatto; che i neri puzzano, hanno un aspetto orribile e assomigliano più a un orango che a un uomo. Letti con gli occhi del tempo, questi testi ci rivelano uno studioso che considerava le colonie americane una tragedia, dal momento che in meno di tre secoli avevano causato lo sterminio della popolazione indigena e ora erano meta di avventurieri e di mercanti dediti “all’industria, tanto vilipesa e censurata, di comprare e vendere uomini di colore nero, traffico che disonora l’uman genere, e che da alcuni governi è stato proibito e da altri sostenuto, malgrado che si vantassero per sommamente civilizzati”. (A. Tuccillo, Il commercio infame. Antischiavismo e diritti dell’uomo nel Settecento italiano, Cliopress, Napoli 2013, pp. 344-346).
 La foga iconoclastica non ha risparmiato i monumenti di Victor Schoelcher, il giornalista e uomo politico francese, promotore del decreto del 1848 con il quale venne sancita la fine della schiavitù in Francia e nelle sue colonie. Su di lui si veda: F. Magris, Rivoluzionario o riformista? Victor Schoelcher e l’abolizione della schiavitù, in “Studi Storici”, 54, 3, 2013, pp. 611-622.
La foga iconoclastica non ha risparmiato i monumenti di Victor Schoelcher, il giornalista e uomo politico francese, promotore del decreto del 1848 con il quale venne sancita la fine della schiavitù in Francia e nelle sue colonie. Su di lui si veda: F. Magris, Rivoluzionario o riformista? Victor Schoelcher e l’abolizione della schiavitù, in “Studi Storici”, 54, 3, 2013, pp. 611-622.
La rivoluzione abolizionista
Due documenti – un gioiello e il brano di un libro – ci fanno intuire la differenza dei tempi. Oggi noi consideriamo normale essere contro la schiavitù. Allora era rivoluzionario. Oggi noi assimiliamo razzismo, colonialismo e schiavismo. Tre secoli fa erano fenomeni ben distinti. Se non recuperiamo lo sguardo di quei tempi, non riusciremo a valutare la portata di quella rivoluzione. Torniamo dunque a Grenouilleau che, lavorando su una massa impressionante di documenti, ci offre una visione realistica di come quella rivoluzione si sviluppò.
Fu una rivoluzione strana, ci avverte il nostro autore. Ha una premessa lunghissima, che affonda nei tempi profondi della civilizzazione occidentale, dagli antichi sofisti e ai loro allievi romani, ai sapienti religiosi e laici di età medievale e moderna. Non era nuova, in occidente (come in altre culture), la considerazione dell’inumanità dell’istituto schiavile. Ciò che è inedito è il fatto che questa disapprovazione si concretizza – alla fine del XVIII in America, in Inghilterra e poi nel resto dell’Europa - nella richiesta della sua abolizione. Non era naturale pensarlo: lo dimostra il fatto che mai (a nostra conoscenza) tale proposito fu espresso nel corso delle numerosissime rivolte che hanno costellato la storia della schiavitù sin dai tempi antichi.
Il movimento transnazionale che nacque alla fine del XVIII secolo, invece, trasformò questa richiesta in un obiettivo politico con una ostinazione e un’intelligenza rimarchevoli: perché la seconda stranezza di questa rivoluzione consiste nella sua lunga durata. Le date ufficiali (se ci limitiamo a queste) ci dicono che durò quasi un secolo, dal 1792, data nella quale la Danimarca per prima proclamò l’illegittimità della Tratta, fino al 1888, quando crollò l’ultimo baluardo dello schiavismo occidentale, il Brasile dell’imperatore Pietro II.
Lo storico ricostruisce l’attività politica di questo movimento, che seppe vincere nonostante fosse minoritario e incappasse in numerose battute d’arresto. Le maggioranze (soprattutto quelle inglesi e francesi) agitavano il rischio delle spaventose crisi economiche che la liberazione degli schiavi avrebbe comportato e la paura delle ribellioni delle colonie. Oppure sventolavano la bandiera nazionalistica, come in Francia, dove si chiedeva ai cittadini di non cedere alle idee provenienti dalla nemica di sempre, l’Inghilterra. Al suo interno, il movimento riusciva a tenere insieme anime diverse: gruppi pietisti americani e inglesi, élites illuminate, intellettuali francesi (ma anche italiani, come abbiamo visto) spesso ostili alla religione, a volte masse operaie, come accadde a Manchester dove ben undicimila cittadini votarono il documento abolizionista. Non necessariamente gli abolizionisti erano anche anticolonialisti. Molti sostenevano un dominio coloniale soft, limitato per esempio al controllo degli empori costieri. Per giunta, dopo la seconda metà dell’Ottocento, quando ci si rese conto che le leggi europee non avevano messo fine al fenomeno, gli abolizionisti spinsero per intervenire sui regni africani anche con i cannoni. (La révolution abolitionniste. Entretien avec l’historien Olivier Grenouilleau).
Una memoria che divorzia dalla storia
In effetti, il mondo extra-europeo non mostrò grande entusiasmo per questa iniziativa. La Cina abolì la schiavitù nel 1909. Il mondo musulmano – teatro della seconda grande Tratta – fu ancora più restio: l’Arabia Saudita la abolì nel 1962 e la Mauritania nel 1980. Questa refrattarietà generale, il persistere della condizione schiavile, illegalmente o sotto altre forme giuridiche, la stessa ostinata avversione alla liberazione degli schiavi che ci racconta la storia americana, dovrebbero insegnarci quanto fu difficile e meritorio avviare e realizzare il percorso politico e culturale che condusse alla illegittimità della schiavitù e alla sua condanna come crimine contro l’umanità.
Oggi, invece, quel periodo viene letto con la lente di un ideale antischiavista, antirazzista e anticolonialista del tutto contemporanea. Usata in questo modo, diventa una lente deformata che occulta i protagonisti di una lotta che ci ha consegnato un’eredità che dovremmo giudicare eccezionale, sia alla luce della storia dell’Occidente, sia nel confronto fra Occidente e resto del mondo. Jessica Moody ci informa che i movimenti antirazzisti puntano a ottenere una Giornata della memoria, esemplata sul modello di Auschwitz (The persistence of memory.Remembering Slavery in Liverpool, “Slaving Capital of the World”, Liverpool U.P, 2020, pp. 181-183). Questo paragone, proprio perché voluto dai movimenti attuali, è illuminante. Quella giornata fu scelta dopo una lunga discussione fra le varie proposte. Venne accettata perché, pur ricordando il genocidio, apriva al futuro (la liberazione del campo). E resta ancora oggi, nonostante la storiografia abbia da tempo messo in luce i delitti dei quali l’Armata Rossa si macchiò nel corso della sua avanzata. All’opposto, sembra che i tabù dello schiavismo impediscano di trovare una data comune, capace al tempo stesso di ricordare le sofferenze passate e di spingere gli uomini a guardare a un futuro migliore. Ne è una buona prova il dibattito svoltosi in occasione della scelta della data della “Giornata nazionale della memoria”, prevista nella legge Taubira: dopo aver scartato tutte le date possibili - dalla rivoluzione di Haiti comunque collegata alla Rivoluzione francese e ai suoi proclami, all’abolizione definitiva del 1848 – i parlamentari francesi hanno ripiegato sul 10 maggio, data della promulgazione della legge Toubira.
Una giornata della memoria istituita per celebrare se stessa è il simbolo, ironicamente istruttivo, di una memoria che ha tagliato i ponti con la storia.
*Ringrazio Luigi Cajani per i suggerimenti e il controllo attento