Autore: Antonio Brusa
La guerra insegnata. Note di didattica per la scuola e per i musei. (Parte prima)
Indice
1. Craonne, la città martire
2. Gallipoli, la spiaggia sacra
3. Perché studiare la guerra?
1. Craonne. La città martire

Craonne si trova nel Nord Est della Francia, sotto le Ardenne, dove si affrontarono soldati di molte guerre, europee e mondiali. Per una di quelle eccezioni che si imparano solo in loco, si pronuncia Cran (ma dubito tutti i francesi lo sappiano). La città è piccolissima, un insediamento sparso, con una vecchia scuola, adibita a mensa, e un palazzo comunale costruito con i fondi del governo svedese (omaggio alla città martire). La città importante più vicina è Laon. A un medievista brillano gli occhi a sentirne il nome. Qui si elaborò la scrittura detta “Laon A Z”, sulla quale molti studenti di paleografia, me compreso, hanno consumato i loro occhi. Anche Laon si dice “Lan”. Ho perso l’occasione di farmene bello, di questa particolare pronuncia, con Franco Magistrale, che mi insegnò quella scrittura. Mi consolo dedicandogli questo piccolo lavoro.
L’alboreto di Craonne è un luogo dello spirito. Cento anni fa era l’inferno. Craonne, infatti, è una cittadina che si trova al termine dello Chemin de Dames. Il nome delizioso di questa lunga vallata viene dal 1700, quando le signore del tempo vi passeggiavano con le loro carrozze. Durante la Prima Guerra mondiale era pronunciato con terrore dai soldati. Quella valle era la linea di contatto fra le armate tedesche e quelle francesi. Nel piccolo palazzo comunale di Craonne, due plastici, forse un po’ ingenui, illustrano efficacemente la situazione militare: le trincee nemiche scorrevano parallele, a volte a pochi metri di distanza; mentre – in alto – dal costone che sovrasta la vallata, i tedeschi mitragliavano e bombardavano i francesi, che cercavano invano di ripararsi dietro fortificazioni di ogni specie.
Quel luogo fu un macello umano. Nella prima giornata di assalti morirono quasi cinquantamila francesi. Alla fine della guerra le vittime furono diverse centinaia di migliaia, da entrambe le parti. Fra di loro, anche cinquecento italiani, di un corpo d’armata inviato dal Regno d’Italia a soccorrere l’alleato in difficoltà. Un quadro, anch’esso alquanto ingenuo, esposto nel comune, ci restituisce il senso di una tragedia ottusa. Ritrae una lunga fiumana di soldati, visti di spalle. Procedono stretti l’uno accanto all’altro verso l’orizzonte, dove c'è Craonne in fiamme, e dove moriranno. Craonne è una metonimia di ogni guerra combattuta sui campi e studiata nelle scuole.
La cittadina di Craonne, ai piedi del costone, fu distrutta dalle artiglierie francesi. Dopo la guerra non venne ricostruita in loco, ma a pochi chilometri di distanza. Al suo posto hanno lasciato crescere gli alberi. Scendi nel parcheggio, dall'auto o dal pullman che scarica i visitatori, e ti dirigi verso il bosco. Ti inoltri per i viottoli. Riconosci facilmente che furono un tempo le strade della città. Ad ogni svolta, un cartello con la foto d’epoca ti avvisa che c’era una piazza, al posto della radura; e più avanti ancora il fornaio e poi la scuola comunale. La vita degli alberi, al posto di quella degli uomini e delle loro cose. Forse è questo il senso di pace, che l'alboreto ti comunica?
 Craonne come è oggi Craonne come è oggi |  e come era prima della distruzione e come era prima della distruzione |
Più in là, verso il costone di roccia, vedo degli operai. Lavorano alle attrezzature turistiche del sito. Strade, scale, giardini curati. Il costone di roccia era stato traforato dai tedeschi, con tunnel e bunker. Uno di questi, la Caverna del Drago, è diventata un museo, al termine del quale si passa in un bar/ritrovo, che si apre sulla valle con una balconata spettacolare. Quello era il punto di vista dei soldati tedeschi, e ora è il mio. Oggi, vedo una distesa di colline morbide, con macchie alberate, fattorie, campi coltivati. Il soldato tedesco scrutava quella distesa ingrigita dal fumo, dai ruderi e dai tronchi bruciati, alla ricerca di nemici da eliminare.
L’ingresso del bunker, chiamato la Caverna del Drago; il belvedere attrezzato del museo omonimo
I cittadini di Craonne trovano nel turismo di guerra una fonte di sostentamento. Non c'è bisogno di una indagine accurata per capirlo. Ho la sensazione, però, che lo facciano con dignità. E' una sensazione, certo. Forse, sono anche influenzato dal fatto che la città non si limita al turismo, ma promuove una ricerca accanita e senza veli sulla guerra e sulla memoria.
La Francia ha un rapporto particolare con la storia. A differenza del nostro paese, è facile che un dibattito storico accenda gli animi della gente comune anche se si parla di fatti accaduti un secolo fa, come è il caso della Prima Guerra mondiale. Detta in parole povere, la questione che divide gli studiosi è questa: per conservare la memoria di quel passato tragico, dobbiamo accettare tutto, usare ogni mezzo, anche la spettacolarizzazione spinta; oppure questa memoria acquista senso e utilità sociale solo se tiene viva la tragedia e l'incomprensibilità del conflitto, che lacerarono – insieme - quei tempi lontani, e quelli che ci separano da loro? Ci dobbiamo battere perché la memoria è un patrimonio da salvaguardare per il solo fatto di riguardare eventi decisivi; oppure dobbiamo lottare – intellettualmente e moralmente - per dare un senso a questa memoria? E che cosa deve dar senso a questa memoria? L'idea che quei fatti sono le nostre radici, il “passato senza del quale non abbiamo futuro”? O può darle senso – e quale? - la puntigliosa ricostruzione della desolazione che quei fatti portarono?
Perché ricordare? Vale anche per la memoria la domanda che il bambino rivolse a Marc Bloch, “perché studi la storia?” E vale anche in questo campo l'ammonimento di Bloch, che gli storici sbagliano, e di grosso, a considerare scontata questa domanda?
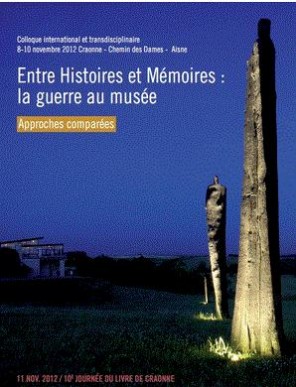
Il programma del convegno su Storia e Memoria
2. Gallipoli. La spiaggia sacra
Quindi, sono a Craonne, insieme con storici che vengono un po' da tutto il mondo, perché ci accomuna il desiderio di raccontarci qualche risposta a questa domanda. Fu una guerra mondiale: dunque non mi sorprende di ascoltare colleghi francesi, italiani, spagnoli, cechi e turchi, canadesi, americani e neozelandesi. Questi ultimi mi incuriosiscono particolarmente. Perché un neozelandese o un australiano dovrebbero porsi oggi il problema della memoria della Prima Guerra mondiale? Certamente, quelle terre inviarono dei soldati. Facevano parte dello schieramento alleato. Questo lo studiamo. Ma, tutto sommato, saremmo portati a pensare che si trattò di una guerra per loro lontana, che sentirono estranea, e quindi facilmente preda dell'oblio. No, ribatte Fanny Pascual, che insegna nell’Università della Nuova Caledonia, informando noi europei che i memoriali della Prima guerra abbondano ai nostri antipodi. Sono luoghi di memoria venerati, oggetto di turismo e di visite incessanti. Sono luoghi di fondazione della nazione.

|

|
Il memoriale di Auckland in Nuova Zelanda e quello di Canberra, in Australia, con i papaveri, i fiori dei soldati, apposti dai visitatori
Normalmente, quando spieghiamo in Italia la Prima guerra, tralasciamo un evento che per noi, per la nostra sensibilità, appare alquanto distante. Al principio del 1915 gli Alleati decisero di aprire un nuovo fronte in Turchia. Organizzarono una flotta e uno sbarco imponenti (la prima operazione del genere, sottolineano gli esperti di storia militare). Ma lo fecero così male che mandarono a morire centinaia di migliaia di giovani: neozelandesi e australiani. Un giudizio, questo, sul comportamento stupido e folle degli ammiragli inglesi che guidarono questa impresa sciagurata, che è condiviso dagli studiosi (lo ritroverete fedelmente su Wikipedia). Motivato, senza dubbio, questo giudizio suona però strano, qui a Craonne, dove uno si chiederebbe perché la condotta dei generali francesi, per quanto sciagurata, sia da considerarsi militarmente corretta.
In quel caso, ad accelerare la disfatta alleata, contribuì l'armata turca, guidata è vero da un generale tedesco, ma animata da Mostafà Keimal Ataturk, il fondatore dello stato turco moderno. Fu lui, dicono le cronache, che ebbe l'intuizione di fortificare i costoni di roccia che sovrastano le striminzite spiagge dove sbarcarono i baldi giovani dall'Oceania. E di lì i turchi, come i tedeschi a Craonne, presero a mitragliarli con comodo. Per questo motivo, conclude Loubna Lahmrari, studiosa marocchina, specialista di storia turca presso l’università di Montpellier, quella spiaggia di Gallipoli è considerata un luogo di memoria e di fondazione della nazione.
Il cinema non poteva mancare all’appuntamento. Nel 1985, Peter Weir girò Gli anni spezzati, con Mel Gibson, nella parte di un giovane australiano che fa il portaordini durante la guerra, non riesce ad evitare il massacro e muore anche lui; la Turchia non è da meno, con ben cinque film, uno dei quali reimpiega Mel Gibson, a carattere più o meno nazionalistico.
La medesima località è diventata un luogo sacro, per due nazioni agli antipodi. E, per giunta, ci dimostra con chiarezza la diversità del ricordo, della memoria e della storia. Per quello della memoria, essa fu teatro di eroismi e martiri. Lo sguardo della storia, invece, pur mettendo in luce le indicibili sofferenze umane che vi furono patite, ricorda che da una parte vi furono dei giovani mandati allo sbaraglio da uno stupido generale; e che dall'altra, altri giovani, per quasi un anno, si esercitarono al tiro al bersaglio umano. La conoscenza, oggi, di quel fatto – potremmo dire “la coscienza storica di quel fatto” - a mio modo di vedere, non consiste nel “dovere di ricordarlo”; quanto, piuttosto, nell'obbligo morale e scientifico di esplorare i meccanismi sociali, culturali e politici, che lo trasformarono in un evento fondatore.
3. Perché studiare la guerra?
Dovremmo riflettere sull’utilità di una “educazione alla violenza”: in altri termini sulla utilità di dotare i ragazzi di un’attrezzatura mentale, che li metta in grado di far fronte a questo aspetto della vita e della storia, che abbiamo quasi del tutto eliminato nella concezione borghese della vita familiare, ma che straripa nei media e, spesso, nelle strade. E questo è oggi necessario. Non sembri paradossale - l’analisi dei manuali non ci lascia alcun dubbio – la guerra è sparita dalla didattica.
Il paradosso nasce dal fatto che, a causa dell’immagine di “storia-battaglia” che la grande rivista francese del secolo scorso “Les Annales” aveva creato per battere la storia tradizionale, e affermare vittoriosamente la propria idea di storia, tutti siamo convinti che gli insegnanti si dividano in due categorie: quelli che spiegano guerre, sovrani e trattati di pace; e quelli che spiegano “la società”. Le battaglie appartengono alla “storia dall’alto”. Ma in realtà: chi la spiega ancora? Ciò che vediamo, invece, è un canone piuttosto deformato, composto da una congerie di tradizioni storiche e storiografiche che si sono fuse e intrecciate fra di loro, attraverso l’uso da una parte, e con la sapiente regia commerciale delle case editrici dall’altra.
Le guerre, dal canto loro, è vero che abbondano e ne troviamo a bizzeffe, pagina dopo pagina. Ma fate attenzione: sono citate, non sono descritte. Solo qualche volta - a proposito di Qadesh, per esempio (la prima battaglia che trovo nei manuali: ma sta rapidamente scomparendo, a causa dei tagli di ore e conseguentemente di pagine); oppure della battaglia navale di Salamina o di quella terrestre di Canne – si trova la descrizione delle manovre degli schieramenti. Ma assai di rado leggeremo la sofferenza, i cadaveri, le ferite, la fatica terribile del combattimento, l’angoscia nella sua attesa, la spossatezza e il vuoto, alla sua fine. Sono guerre senza soldati e senza sangue. Tutto questo sia perché i testi, in genere, diventano più freddi e impersonali; sia perché l’intero apparato emotivo della comunicazione storica viene trasferito nelle immagini: e queste, sempre di più invadono i nostri manuali (e c’è da pensare che l’incipiente vicenda della storia in rete non farà che aumentare questa tendenza). Potremmo dire che la guerra dei manuali è il luogo dove si palesa la vittoria della “civiltà delle buone maniere”, che – secondo Norbert Elias – ha pian piano ripulito le nostre case dalle tracce di violenza e di sporco.
Le eccezioni sono anch’esse significative. In occasione della prima, ma soprattutto della seconda guerra mondiale, si fa largo la descrizione della “sofferenza della popolazione”. Il martirio del fronte interno: il cibo razionato, il freddo, le donne al lavoro maschile, i bombardamenti. E, soprattutto in occasione della prima guerra, troviamo spesso il tema della “vita delle trincee”. A mio modo di vedere, queste pagine hanno molto a che vedere con l’ideologia della “gente comune”, e quindi, pur ponendosi esplicitamente come “critiche” e come “inviti alla riflessione”, corrono il rischio di ribadire convinzioni comuni e ormai scontate.
Due eccezioni ancora mi sembrano significative, in questo occultamento della violenza, ma sono così importanti che richiedono un discorso a parte. La prima è quella della violenza “sacra”. Quella appunto che porta all’indipendenza della nazione, o alle lotte per la sua sopravvivenza. Per quanto in declino, essa è ancora presente, con modalità diverse e interessantissime da studiare, da nazione a nazione. La seconda riguarda la Shoàh: il racconto della violenza assoluta. Nei tempi recenti è diventato (e anche di questo occorre discutere) paradigmatico al punto tale che tende a sopraffare quello dominante negli ultimi decenni del secolo scorso, il racconto della Resistenza.
I morti delle guerre manualistiche non sono mai “cadaveri”. Al massimo numeri. Settantamila romani uccisi a Canne; cinquanta milioni di morti nella seconda guerra mondiale. Indici di grandezza della guerra. Inoltre, più si risale verso il passato, più queste vittime assumono i colori dell’epica. Ecco la battaglia di Maratona. Migliaia di morti nell’esercito persiano e “solo” poche decine di ateniesi. Ecco la conquista della Gallia o della Dacia. Centinaia di migliaia di barbari uccisi e un milione catturati e fatti schiavi. Il ragazzo impara la potenza di Roma.
Non voglio discutere o criticare il racconto epico della guerra. La rielaborazione dell’evento, nella letteratura come nel gioco, fa parte integrante del nostro modo di gestire questi fatti terribili. Il punto è: e la storia? Si deve limitare a citare questi fatti, alle loro descrizioni fredde e asettiche, e, in pratica, li deve occultare? E, magari, deve lasciare al “tema di attualità”, o all’ora di filosofia o di religione, il compito di tematizzarne e raccontarne l’angoscia? Eppure la storiografia ha elaborato potenti sistemi di indagine su questi eventi. Privarne gli allievi non sembra una scelta molto acuta.
A molti sembra un progresso, non parlare di guerre. Spiego la vita dal basso, della gente comune, la storia di genere o le mentalità. Oppure, come si dice, “spiego la pace”. Giusto: ma non spiegare le guerre significa circondare questi fatti con un recinto di protezione, che li separa dalla storia e li confina nell’empireo degli oggetti scolastici. Li priva della loro problematicità e, perciò, li de-storicizza.
Noi cercheremo di indagare su questo fenomeno, servendoci di una fonte e di un luogo particolari: i musei di guerra. Molto diffusi in altre nazioni (in Francia in particolare), in Italia sono presenti per la maggior parte in Italia Settentrionale e, ovviamente, con una concentrazione maggiore nelle regioni investite dalla Prima Guerra mondiale. Non mancano i musei del Risorgimento, che di recente hanno conosciuto un momento di risveglio dopo un lungo torpore: anche loro, si ricordi, sono in gran parte musei di guerra. Ho escluso da questa ricerca i musei della Resistenza: per questi occorreranno un discorso e uno studio particolari.
Studiare la guerra nei musei serve non solo ai loro operatori. E’ utile anche per gli insegnanti. Come tutti sanno, la collaborazione fra insegnanti e operatori è fondamentale per un buon uso didattico del museo. Ma, oltre a questo, lo studio delle scelte espositive del museo aiuta docenti e storici ad approfondire questo argomento. Ci fornisce conoscenze e idee per spiegarla bene, e fare – della guerra – un oggetto di buona didattica.
Fine prima parte
(Seguirano la Parte seconda, sui musei tradizionali e i “musei-manuale”; la Parte terza sui “musei-laboratorio” e i “musei-provocazione”. Questo contributo è la rielaborazione della relazione che ho tenuto al convegno di Craonne, e che verrà pubblicata in Francia)