di Antonio Brusa
1. Una buona idea: aumentiamo le ore di storia.
 Insegnare è difficile
Insegnare è difficile
Delle tre proposte di riforma dell’insegnamento storico, che Mariangela Caprara formula su “il Mulino” di settembre, la seconda è quella da sottoscrivere senza esitazione. Questa: «L’incremento delle ore settimanali di storia, distinta dalla geografia (sul cui insegnamento sarebbe auspicabile una seria riflessione a parte), sempre fino alla conclusione dell’obbligo scolastico, è il secondo passo indispensabile. Un numero di ore adeguato è necessario non già per trasmettere una grande quantità di informazioni/nozioni, ma per consentire lo svolgimento della didattica anche in forma laboratoriale e collegata con le realtà territoriali (musei, biblioteche, archeoclub, associazioni)».
Quante ore in più? Mi accontenterei di tornare agli assetti pre-riforma Moratti: con gli insegnanti di area storico-geografica delle elementari che potevano gestire 9 ore settimanali; gli insegnanti delle medie che usufruivano di quattro ore la settimana, con un “bonus” di 30 ore per quelli di terza, per insegnare Educazione Civica, e con il reintegro degli orari specifici delle superiori. Certamente: ricordo molto bene le lamentele dei colleghi degli anni ’80-’90 (che il tempo non bastava, che il programma era troppo vasto ecc.). Ma i tagli che a quegli orari sono stati operati dal duo Moratti-Gelmini (la prima li ha pensati, la seconda realizzati), sono talmente disastrosi che sarei soddisfatto se tornassimo alle dotazioni di venti anni fa. Si è perso da un terzo a oltre la metà del vecchio curricolo di studi, col trucchetto della geostoria, l’abolizione dei moduli nelle elementari e l’introduzione di un’Educazione alla Cittadinanza che, in qualche istituto, porta la Storia, la Geografia e l’Educazione Civica a materie da un’ora la settimana.
Scrissi allora che Gelmini, volendo introdurre una nuova disciplina, ne stava eliminando tre. È quello che sta, purtroppo, accadendo.
Credo che qualsiasi discorso sullo stato della conoscenza storica nelle nostre scuole non possa che transitare da queste forche caudine: avete diminuito le ore. Come potete pensare che l’insegnamento non tenda a peggiorare?
2. Può andar peggio? Sì
In realtà, il fondo non è stato raggiunto e possiamo ancora peggiorare. E un potente incentivo a farlo viene involontariamente, proprio dai buoni propositi di alcuni colleghi. Ne è un esempio la prima, delle proposte di Mariangela Caprara. Eccola:
«Che fare? Innanzitutto, va ripristinato il sistema “a spirale” dell’apprendimento dei contenuti, con la ripetizione di tutto il percorso cronologico dalla preistoria all’età contemporanea in 5 (scuola primaria) + 5 (medie + biennio = assolvimento dell’obbligo scolastico) + 3 anni, tenendo conto del limite attuale dell’obbligo scolastico, ossia i 16 anni».
Attenzione: non conviene invertire i tempi. PRIMA occorre la certezza della restituzione delle ore; DOPO si può pensare ad una diversa distribuzione della materia. Prendiamo il caso della primaria. Attualmente, la storia generale inizia in quarta (e non in terza, come scrive Caprara) e si completa con la secondaria di primo grado. Se, come si suggerisce, si tornasse al vecchio programma SENZA l’incremento di ore corrispondente, gli insegnanti di primaria dovrebbero svolgere l’intera storia generale, avendo a disposizione una o due ore la settimana (si varia a seconda degli istituti). Se già al tempo della ministra Falcucci (metà degli anni ’80), l’insegnante elementare, pur disponendo di un numero di ore molto maggiore, si lamentava del fatto che non riusciva a “terminare il programma”, in quali condizioni lo metterebbe il compito di lavorare su tutta la storia, con il risicato monte ore di cui dispone oggi?
3. Il male minore, purtroppo.
Quindi: INNANZITUTTO, restituite a storia/geografia le ore perse. Poi battaglieremo su che storia insegnare e come insegnarla. Altrimenti, la soluzione che a suo tempo fu elaborata da Moratti, cioè quella di “spalmare” il vecchio programma triennale della media in cinque anni, resta la via d’uscita meno dolorosa. Non conviene invertire i tempi nemmeno per quanto riguarda gli assetti strutturali. Oggi, il grande problema del primo ciclo è la difficoltà di saldare il lavoro dei maestri con quello dei professori. È denunciato da molti, ma si fa poco per suggerire proposte (e realizzarle). Eppure, nella maggior parte dei casi, entrambi lavorano nel medesimo istituto comprensivo. Nella proposta di Caprara, di un ciclo composto da medie+biennio (perdonatemi le vecchie definizioni, ma sono enormemente più veloci), si pensa che il collegamento fra i due gradi, corrispondenti a istituti che spesso non hanno nulla in comune, sia più facile?
Probabilmente, la collega Caprara, pur insegnando in un Liceo Classico, non ha presente la realtà degli insegnanti del biennio, che si trovano una classe composta da allievi che provengono da istituti i più disparati. Come faranno, quei docenti, ad “agganciarsi” all’insegnamento precedente, se non a partire da una “comprensivizzazione” (passatemi il termine) di media e biennio? E quando questa venisse prospettata, quale sarebbe il destino del liceo classico?
È il caso di ricordare che il timore di mettere mano all’assetto quinquennale della secondaria superiore è di quelli che immediatamente fanno scattare proteste corali, guidate spesso proprio dai sostenitori del Liceo Classico.
4. La terza proposta di Caprara
«Il terzo passo è il più difficile, perché è il più rivoluzionario: affidare l’insegnamento della storia esclusivamente a laureati in storia, chiudendo così la stagione, non proprio felice, della storia insegnata insieme all’italiano e alla filosofia da laureati in discipline non storiche, sia alle medie sia alle superiori».
Si tratta di una delle richieste più antiche dei colleghi storici, e la questione di apparentamenti disciplinari che penalizzano la Storia è un topos di quasi tutti gli interventi didattici del dopoguerra.
Confesso che, quando facevo parte della Commissione De Mauro, e vi si ragionava di un’area geo-storico-sociale, pensai realmente che fossimo vicini alla soluzione di questo annoso problema. Forse sognavo: due ore di storia, due di geografia e una di scienze sociali/educazione civica. Cinque ore la settimana lungo tutto il curricolo. Ne viene una cattedra che sta su tre/quattro classi. Gestibile dal docente, che si avvantaggia di una “presenza” in aula significativa e rispettata dall’allievo.
Erano tempi nei quali si poteva pensare anche ad una formazione coerente tra i vari gradi di scolarità. Infatti, ne parlai con i colleghi della mia Facoltà e in poco tempo varammo un corso di laurea in Storia e Scienze Sociali. In tante altre Facoltà non si pensò diversamente. Certamente, non si trattava del professore di “sola storia”. Ma la compagnia delle scienze sociali e della geografia è indubbiamente più consona al nostro mestiere di quella, pur rispettabile, dei letterati e dei filosofi.
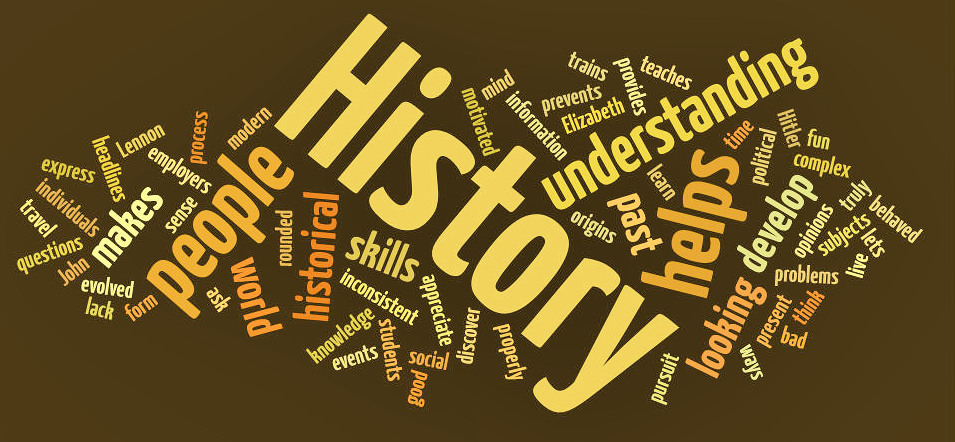 Storia
Storia
Finì come sapete. O forse no. Forse tutti conoscono le traversie universitarie, il crollo dei corsi di laurea. Ma non è altrettanto noto che ci sono istituti scolastici nei quali un insegnante combina nella sua cattedra nove ore di geografia, o nove di educazione alla cittadinanza in nove classi diverse. 270 allievi: di che qualità dell’insegnamento possiamo parlare?
Né è più appagante la cattedra di chi entra in classe per due ore la settimana. Il fatto è che, con l’autonomia, di insegnanti di “sola storia” ce ne sono già in giro, e non sembrano gli insegnanti più felici del mondo. Chi insegna, sa quanto “vale” agli occhi del discente un insegnante da un’ora/due la settimana, per quanto questi possa essere uno “specialista della disciplina”.
Conti della serva, conti penosi. È vero. Ma se non li teniamo presenti, rischiamo di produrre degli specialisti condannati a essere professori ben oltre l’orlo della crisi di nervi.
5. Tempi di riforma
Si avvicinano i tempi della riforma dei programmi. Non so se questo è stato il motivo che ha sollecitato «Il Mulino» a pubblicare l’articolo di Caprara (che peraltro interviene frequentemente sia questa rivista, sia sul blog Le parole e le cose, molto attento alle questioni scolastiche). Ma sono abbastanza sicuro che, non appena si cominceranno a conoscere i risultati dei lavori delle Commissioni, che credo già all’opera, a questo articolo (e a qualcun altro che nel frattempo è già apparso) ne seguiranno degli altri.
Spero che la discussione pubblica non perda di vista il contesto nel quale le riforme si debbono realizzare, e lasci perdere principi astratti, per nulla supportati da riscontri scientifici (come la pretesa superiorità dell’insegnamento ciclico a spirale). Per quanto mi riguarda, non ho nulla contro l’idea di fare del blocco media+biennio il cuore del curricolo verticale di storia, che credo di essere stato il primo a formulare in Italia alla fine degli anni ’90 (quando ne scrissi, i burocrati del Ministero inventarono, per descriverla, il termine “scavalco”, fortunatamente andato in disuso).
Ma perché questa riforma sia fattibile, occorrono altre condizioni. Allora, con il primo governo Prodi, pensammo che si potessero ottenere. Ci eravamo sbagliati. Ma possiamo ritenere da quegli errori la consapevolezza che mettere in atto un dispositivo formativo verticale, senza avere la garanzia di precisi collegamenti fra i gradi scolastici che lo debbono mettere in pratica, non sia un’operazione saggia.
Se si volesse andare indietro negli anni, e cercare che cosa non ha funzionato, alcuni elementi balzano agli occhi con evidenza tale, da non poter essere trascurati. Il primo è la mancanza di aggiornamento sui programmi della scuola di base, pur essendosi questi auto-presentati come innovativi. Il fondo che ha finanziato, per esempio, l’aggiornamento del programma Profumo è stato così irrisorio da giustificare la diffusa ignoranza del dettato legislativo. Ne è una prova autorevole la stessa Caprara che non sa che la storia generale inizia in quarta, che non sa che NON è per nulla suggerito di studiare i dinosauri in terza (come aveva invece prescritto la Moratti) e che le attività propedeutiche del primo triennio elementare devono avere precisi caratteri storici (quindi vi si può proporre lo studio della storia, anche contemporanea). Ma la prova più evidente di questa disattenzione generale è che i manuali sono costruiti in omaggio a un senso comune diffusissimo nelle scuole, che è appunto quello di una terza elementare concepita come un kindergarten della preistoria.
Il secondo è che i programmi che attualmente sono in vigore nella secondaria superiore, a differenza della scuola di base, si presentano come restaurativi. Riprendono, a volte quasi alla lettera come per la parte Medievale, le indicazioni dei programmi del 1960. Programmi allora innovativi, oggi nati vecchi di mezzo secolo.
Questi fatti (insisto: fatti) presentano al legislatore due problemi. Il primo è quello di armonizzare un curricolo discontinuo. Deve decidere, e deve affrontare su una base chiara il confronto con la scuola. Il secondo è che (vuoi per la mancanza di aggiornamento disciplinare nella scuola di base, vuoi per la volontà politica nelle superiori), lo zoccolo duro dell’insegnamento storico italiano è ancora quello tradizionale. Se si vuole cambiare per migliorare le cose, è lì che bisogna agire.
Link immagine Link immagine