di Antonio Brusa
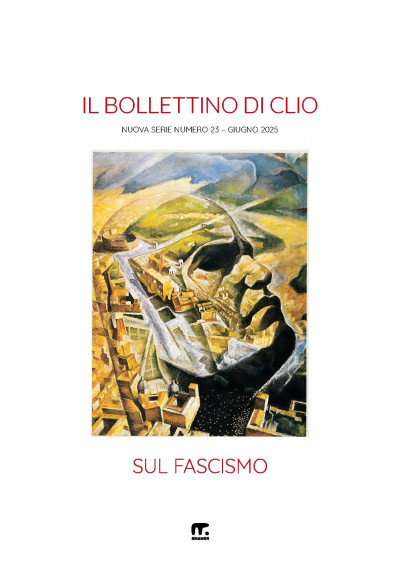 Perché è importante studiare la storia? Emilio Gentile ce lo spiega nell’intervista che apre il 23° “Bollettino di Clio”, dedicato al fascismo. Segniamoci le sue parole, perché non valgono non solo per quel periodo, ma per ogni fatto sconcertante, del passato come del presente:
Perché è importante studiare la storia? Emilio Gentile ce lo spiega nell’intervista che apre il 23° “Bollettino di Clio”, dedicato al fascismo. Segniamoci le sue parole, perché non valgono non solo per quel periodo, ma per ogni fatto sconcertante, del passato come del presente:
“La conoscenza critica del passato è lo sviluppo di una personalità razionale e realistica, che non si ritrae mai dal capire come e perché sono accaduti certi fenomeni, anche i più orrendi e ripugnanti alla nostra coscienza soggettiva, così come uno studioso del cancro non si ritrae dall’indagare le sue manifestazioni più distruttive”.
Il Bollettino, curato da Giuseppe di Tonto e Saura Rabuiti, raccoglie 12 saggi, 4 esperienze didattiche e 6 letture su questo argomento. Se scorrete l’indice, vi scoprirete tutti i temi che ne animano, ancora oggi, l’interesse. Li trovate accorpati e ben descritti: un’operazione necessaria per insegnare, data la vastità ormai non più contenibile degli studi. Basti pensare che la sola Wikipedia dedica a questo tema ben 364 voci (Prampolini: ma scorrendo gli indici di Historia Ludens ne troverete molte altre).
Così abbiamo, in questo Bollettino, sia l’interpretazione “stretta” del fascismo, quella alla quale Alberto De Bernardi ha dedicato le sue pagine più appassionate, riportata nell’intervista a Gentile, il quale ci avverte che questo termine ormai racchiude una “nuvola” di significati che lo rende applicabile ad ogni fenomeno spiacevole, e ci consiglia di tornare (o di conservare) all’interpretazione rigorosa, di un regime conquistato da un partito armato, con la violenza, e ammantato di ideologie mitizzanti; sia l’interpretazione “larga”, quella resa celebre da Umberto Eco, con il suo modello di Ur-Fascismo, spiegata qui da Giorgio Barberis.
Molti articoli affrontano, quindi, il tema del rapporto tra fascismo e storia della Repubblica, fino all’oggi, al fatto cioè che due massime cariche dello stato sono rette da persone che provengono da movimenti storicamente collegati al fascismo. Fino al problema, caldissimo, della costruzione continua di “contromemorie”, ben spiegato da David Bidussa.
Vi si parla di didattica, con l’analisi dei manuali di Enrico Pagano, organizzata in poche parole chiave, e con varie proposte didattiche, fra le quali ricordo quella raccontata da Marco Cecalupo sull’uso della fotografia durante il fascismo, un must di Historia Ludens, quando coi miei ragazzi invadevamo le scuole di Bari (e non solo).
Insomma, un Bollettino da scaricare e conservare nel proprio archivio.




















