Pietro Manca e la I B, Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone”, Copertino (LE)
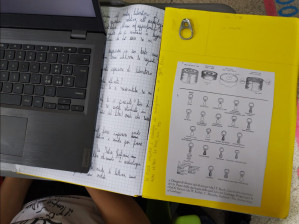 Possono gli oggetti aiutare a comprendere la storia? Possono contribuire all’insegnamento della storia? In che modo è possibile fare didattica con l’utilizzo degli oggetti? E lo studio degli oggetti non è tipico delle archeologie del mondo antico? Che c’entra con la storia contemporanea?
Possono gli oggetti aiutare a comprendere la storia? Possono contribuire all’insegnamento della storia? In che modo è possibile fare didattica con l’utilizzo degli oggetti? E lo studio degli oggetti non è tipico delle archeologie del mondo antico? Che c’entra con la storia contemporanea?
Queste le domande che ci vengono in testa, sfogliando il libro di Giuliano De Felice L’archeologia del contemporaneo in 10 oggetti, edito da Laterza nel 2024.
Sentiamo l’autore
Sembrerà strano, ma per un archeologo che si occupa di Età contemporanea, non c’è differenza così marcata fra il modo di vedere delle popolazioni in Età antica, medievale e, entro certi limiti, anche moderna; seppur con livelli sociali e tecnologici molto diversi tra loro, è possibile trovare un tratto univoco che lega le prime comunità neolitiche alle soglie dell’Età contemporanea (pp. XIV-XV).
Questo libro non vuole essere una storia del mondo contemporaneo narrata attraverso gli oggetti. Non si tratta di scovare reperti misteriosi, ma piuttosto di partire da alcuni manufatti apparentemente insignificanti o poco appariscenti per provare a collocarli nel contesto in cui sono stati in vita. Da un punto di vista archeologico, in altre parole, proveremo a ripercorrere la biografia attraverso le vicende della loro produzione, del loro uso, del loro riuso e del loro abbandono, ricostruendone le relazioni con alcuni temi della storia contemporanea (p. XVI).
Ho cercato, con gli alunni della classe prima, di entrare nel vivo della narrazione che Giuliano De Felice fa dell’archeologia del contemporaneo per motivare, invogliare e sollecitare gli studenti allo studio di oggetti che, seppure lontani dalla loro esperienza, vi entrano ordinariamente lasciando tracce tutte da scoprire.
Coerentemente con quanto suggerito dalle Indicazioni Nazionali del 2012 (da tenere sempre presenti nel nostro lavoro) “L’apprendi¬mento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. (…) Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso”.
“Le conoscenze prodotte dagli storici, innumerevoli e in continuo accrescimento, sono sottoposte a revisione continua a seconda del mutare dei rapporti tra presente e passato e della continua reinterpretazione delle fonti. La scuola tiene conto di questo e, in modo via via più accurato, in relazione alle diverse età e alle capacità cognitive degli alunni, progetta percorsi didattici che approfondiscono la conoscenza della storia e l’attenzione alle diverse fonti”.
Dunque, le conoscenze prodotte e segnalate da Giuliano De Felice, nel suo L’archeologia del contemporaneo in 10 oggetti, sono servite per studiare, approfondire e produrre nuove competenze rendendo nuovi e interessanti oggetti di uso comune, che mai avremmo pensato di usare in un laboratorio storico. Un modo differente di costruire un laboratorio didattico dello storico e aggiungere nuovi strumenti per chi insegna, ma sempre molto facili, perché come scrive lo stesso De Felice: «L’archeologo non è un super eroe, non ha superpoteri e non ha scelto di prendere la pillola rossa per vedere quant’è profonda la tana del coniglio bianco» (p. XVII).
Nella prima parte dell’anno scolastico 2024/’25, insieme agli studenti, ci siamo avventurati nella scoperta delle tin can (le lattine di birra e di altre bevande): «Oggetto semplice e quotidiano, strumento essenziale di approvvigionamento e conservazione di alimenti e di ogni genere di prodotti, ma anche simbolo della frontiera americana e oggetto d’arte: la tin can è uno dei reperti di epoca contemporanea più studiati dagli archeologi americani e non solo. Tecniche produttive, diffusione e reimpiego ci aiutano a ricostruire la vita di nativi, pionieri, cercatori d’oro, cacciatori di pellicce, minatori, soldati e semplici cittadini fra Ottocento e Novecento» (p. 19).
Dunque, i ragazzi hanno cercato di capire che cosa la tin can - e la relativa “linguetta”- racconta della storia contemporanea. Più di tanti freddi schemi didattici, valgono le loro parole:
Martina dichiara con grande sincerità e chiarezza: «Questa esperienza è consistita nell’osservare come erano le vecchie linguette delle lattine, di solito noi studenti ricerchiamo su Google il sito apposito che parla proprio di questi argomenti, e uno o più alunni leggono il risultato della ricerca per tutta la classe. Da questo percorso ho imparato che molte cose cambiano soprattutto con l’idea di futuro, ma sono molto importanti per il passato. Sinceramente io non ho mai trovato difficoltà con il nuovo lavoro che stiamo facendo, perché ho capito tutto della lezione che ha spiegato il prof.. Questa attività mi è piaciuta molto, è stata molto interessante e penso di avere imparato tanto sulla storia delle lattine e sul loro utilizzo. Penso, se avessi studiato solo su un libro che non sarebbe stato lo stesso.»
Cristian le fa eco: «Questa esperienza laboratoriale è consistita nel farci imparare la storia delle lattine ma con un metodo diverso. Da questa attività ho appreso molte cose che prima non conoscevo e non mi interessavano. Per esempio: prima non sapevo che tanti anni fa, insieme alla linguetta veniva tolta una piccola parte e adesso invece viene lasciata. Studiando questo argomento non ho trovato difficoltà, il professore ha spiegato con chiarezza e io mi sono trovato bene. Mi è piaciuto molto questo laboratorio perché mi aiuta ad acquisire un metodo di studio che non ho mai provato e sinceramente preferisco studiare con questo metodo che con quello tradizionale.»
Leggere, ricercare, confrontarsi, discutere, correggere, rimodulare sono verbi che esprimono l’entusiasmo del lavoro laboratoriale. Sono espressioni emerse nel debriefing al termine delle attività di gruppo. Lo spiega bene Margherita: «Questa esperienza è consistita nell’ osservare e studiare come erano le “Pull Tabs”, le linguette di molti anni fa. Cercando alcune informazioni nel libro di Giuliano DE Felice abbiamo ricavato interessanti informazioni, anche storiche. Da questa attività ho imparato che le cose non sono sempre state così come le conosciamo oggi, ma che cambiano anche nel corso di pochi anni. Sinceramente, ho capito tutto senza alcun problema, perché una volta aver compreso l’argomento introdotto in classe dal prof. mi è risultato molto semplice. Personalmente, questo tipo di attività è piaciuta molto soprattutto perché è stato un modo diverso di fare storia, ho imparato anche cose nuove non senza divertimento. Ritengo utile fare ricerche e “portare” lattine a scuola -per studiarle- al posto del solito libro da studiare.».
L’innovazione didattica passa anche attraverso queste semplici attività in cui il laboratorio storico è il luogo privilegiato del confronto e dell’apprendimento. Anche Francesco lo evidenzia: «A me questa attività laboratoriale è piaciuta molto, perché mi piace scoprire delle cose nuove e soprattutto del passato. Non ho incontrato difficoltà. Inoltre, questo tipo di attività mi è piaciuta particolarmente perché è come se mi avesse aiutato a tornare nel passato per scoprire -dal vivo- queste cose importanti. Se avessi studiato in modo “tradizionale”, cioè con il libro di testo, non mi sarebbe piaciuto molto.».
E, come conclude, Annapaola: “meno male che hanno scritto un libro sullo studio degli oggetti del passato”! «Con le attività di questo laboratorio ho imparato che anche gli oggetti più comuni hanno una immensa storia alle spalle e in questo caso le linguette, di cui ho imparato l’evoluzione negli anni e che una volta si staccava un pezzo in più. Abbiamo accennato anche qualcosa sulle lattine. Questo laboratorio è stato molto bello e istruttivo, un modo creativo di studiare gli oggetti e la loro evoluzione negli anni. Mi è piaciuto -anche- che abbiano un libro intitolato “Archeologia del contemporaneo in 10 oggetti”».
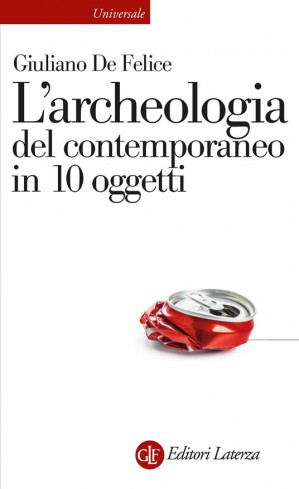 Un’attività didattica che è anche una recensione
Un’attività didattica che è anche una recensione
Il volume di Giuliano De Felice ha accompagnato l’annuale attività laboratoriale di storia; abbiamo letto con attenzione le sue ricerche ricavando informazioni utili agli studenti che appartengono alla generazione Alpha, oltremodo tecnologica. E, in tempi di crisi, non solo in ambito educativo e scolastico è davvero utile affidarsi alle parole conclusive dello stesso autore per formulare un grande augurio al nostro presente: «Non sappiamo se l’umanità sopravviverà allo squilibrio che ha creato né quanto durerà il suo futuro, ma siamo certi che fin quando costruirà, userà, trasformerà e distruggerà oggetti e luoghi sulla Terra o nello spazio più profondo, l’archeologia continuerà a offrire il suo sguardo allo studio e alla ricostruzione di ogni passato e, perché no, anche del presente» (p. 179).






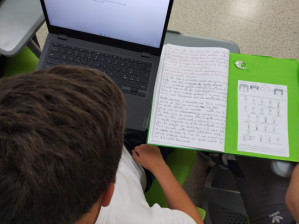















Commenti
Mi chiamo Therese Marie Poulain e sono una professionista del prestito di denaro con contratto privato con diverse banche e istituzioni finanziarie.
Il nostro obiettivo comune è quello di incoraggiare e sostenere le persone in difficoltà finanziarie.
Siamo dinamici nel concedere un prestito in 48 o 74 ore in tutta Europa.
Possiamo concedere prestiti a partire da 5.000 euro fino all'importo di cui avete bisogno a un tasso ragionevole del 2%.
Se avete problemi finanziari o difficoltà a chiedere un prestito in banca e siete alla ricerca di un prestito tra privati, contattateci direttamente all'indirizzo: poulainmarietherese39
RSS feed dei commenti di questo post.