Natale, festa di lotta e di intercultura
Ricorre sulla stampa, quasi ad ogni Natale, la notizia che in qualche scuola italiana le maestre hanno proibito presepi e feste natalizie in ossequio all’intercultura. Il presepe continua a fare scandalo, e non solo in Italia. Quest’anno “Le Monde” dava conto delle proteste di un parroco parigino, infuriato per un allestimento poco tradizionale del presepe. Non mi entusiasma eccessivamente l’idea del presepe nelle scuole o nei luoghi istituzionali (o anche nelle università, come accade spesso nel mio dipartimento). Ma sono del tutto dubbioso sull’efficacia che la sua interdizione possa avere nella diffusione di una prospettiva interculturale, che allude piuttosto ad una cultura aperta, pronta agli scambi, curiosa, piuttosto che ad un modo di guardare il mondo regolato da chiusure e da divieti. E, ancora, mi appare molto strano, e degno di qualche attenzione, il fatto che una festa così meticcia e mescolata fin dalle sue origini (dal momento che assembla fatti pagani, gnostici, dell’ortodossia cristiana, e popolari di varia provenienza), diventata con il tempo il luogo per eccellenza delle atmosfere familiari e ireniche, possa diventare il pretesto per prese di posizioni fondamentaliste ed esclusive.
Mi chiedo come mai l’approccio interculturale sia rapidamente diventato, nello spazio di due o tre decenni, una disciplina (con i rigori che ne conseguono) e rischi in diverse occasioni di far nascere nuovi dogmi, da aggiungere a quelli che la storia ci ha regalato. Dovrebbe, a mio modo di vedere (e naturalmente non solo mio, né pretendo di averlo inventato io), caratterizzare lo stesso approccio allo studio dei fatti culturali. Indispensabile, in particolare, nel momento eccezionale di trasformazione che tutti stiamo vivendo. Ci deve ricordare ciò che è vero sempre, ma oggi più che in altri periodi storici: ciò che consideriamo “cultura” è in realtà un processo. Noi ne viviamo una fase piuttosto movimentata, che ha bisogno di tutto, meno che delle spade al servizio di ideologie sclerotizzate.
Entra in scena Akbar
Faccio questi ragionamenti mentre mi aggiro nella mostra romana su Akbar, il grande imperatore moghul. Akbar era musulmano, imperatore in quel delle Indie nel XVII secolo. Del Cristianesimo conosceva quello che gli avevano raccontato i missionari gesuiti, che i portoghesi sbarcavano a frotte a Goa. Era un appassionato di religioni. Di tutte le religioni. Perciò, si fece venire immagini e testi dall’Europa e li fece ricopiare. Non sapeva leggere, come accadde a molti grandi imperatori. Dunque, aveva bisogno di discutere con missionari e preti di ogni genere, e aveva bisogno soprattutto di immagini. Nelle sue raccolte c’erano crocifissioni, deposizioni, scene del vangelo, immagini di apostoli e di missionari, insieme con le immagini e i testi di innumerevoli culti indiani, persiani e cinesi.
Il presepe di Akbar
Ed ecco il presepe che si fece dipingere da uno dei suoi più grandi artisti Manohar (1580-1620). Osserviamolo: i protagonisti, Giuseppe e Maria, hanno volti occidentaleggianti e sono ritratti con la tecnica del chiaroscuro, che i pittori indiani hanno appena appreso dalle stampe europee. Il paesaggio, invece, è decisamente indiano e, se alziamo lo sguardo al cielo, vediamo delle nuvole disegnate con uno stile chiaramente cinese, così come cinese è il vasellame di porcellana, sparso per terra o portato dagli angeli. Questi, a loro volta, vengono certo dalla Persia, e ce ne accorgiamo per il fatto che hanno il piumaggio attaccato al corpo, sconosciuto in Occidente, dove gli angeli hanno corpo apparentemente umano e solo le ali da uccello.
 Manohar, Natività (1600-1602) Manohar, Natività (1600-1602) |  Il vasellame cinese Il vasellame cinese |  Le nuvole cinesi Le nuvole cinesi |
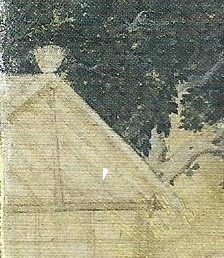 Il paesaggio indiano Il paesaggio indiano |  Il chiaroscuro europeo Il chiaroscuro europeo |  E l’angelo persiano E l’angelo persiano |
Akbar si era circondato dei migliori pittori e disegnatori indiani. Aveva creato scuole d’arte, dove si sperimentavano tecniche nuove e nuovi soggetti; dove si mescolavano modalità di rappresentazione occidentali e orientali. Si faceva inviare dall’Europa stampe e disegni, forse anche quadri, e ingiungeva ai suoi di copiarli e di far proprie le tecniche straniere.
Luca, santo europeo e no
Mi impressiona, più di ogni altro, il San Luca Evangelista, ricopiato da una stampa di Hans Sebald Beham, un incisore tedesco straordinariamente prolifico, della prima metà del XVI secolo (1500-1550: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/58653/Hans-Sebald-Beham ). L’autore indiano è molto fedele all’originale. Di suo ci mette i colori vivacissimi, quelli tipici delle miniature indiane del periodo. Ai piedi del santo disegna due cani, in luogo del toro (il simbolo dell’evangelista), un animale la cui presenza era per lui incompresa, o anche imbarazzante, dato il ruolo dei bovini nella cultura indiana. I cani da caccia sono animali di corte, forse a suo giudizio erano maggiormente degni della nobiltà del personaggio.
L’effetto e il contrasto mi sorprendono. L’incisione tedesca nasce in un clima di lotte religiose feroci. E’ il momento di Lutero, della reazione cattolica e delle prime sanguinose guerre di religione. Il santo europeo campeggia su uno sfondo severo, di solidi geometrici, privo di concessioni. Predica il verbo e rivolge al suo pubblico uno sguardo intenso. Il santo indiano, invece, porta a spasso i suoi libri in un paesaggio ameno. Sicuramente non è un predicatore, e, per di più, ha perso l’aureola (immagino che in India non sapessero che farsene). Hans Sebald Beham fu accusato di eresia e rischiò di brutto. Peraltro, sappiamo che le incisioni (le sue e quelle di decine di altri artisti) erano esse stesse strumenti di guerra ideologica. Stampate in innumerevoli copie, e diffuse anche fra gli illetterati, si rivelarono una delle armi più utilizzate nella contesa interreligiosa europea.

|

|
Trasportato in un’altra parte del mondo, e nel clima di tolleranza signorile della reggia di Akbar, questo san Luca ha messo da parte ogni animosità. Rivela l’atteggiamento curioso della corte indiana, che lo circonda di un alone di favola, ravvivato da colori gradevoli. Questo pubblico, che non sa nulla delle guerre di religione che stanno insanguinando l’Europa, ama le rappresentazioni piacevoli. Ma, per quanto non sembri capire molto del cristianesimo, lo considera ugualmente degno di rispetto e di venerazione.
E’ molto studiata, per quanto riguarda le lingue, la questione della traduzione. In tanti ce ne hanno spiegato le difficoltà, le impossibilità addirittura, ma anche gli spazi mentali che essa apre. Tradurre è tradire e, al tempo stesso, guardare quell’oggetto da un altro punto di vista, impensabile, a volte, dall’autore, o nella lingua originaria. Suppongo che esistano studi analoghi per la “traduzione delle immagini”. Non li conosco purtroppo: ma mi sembra corretto affermare, che queste rappresentazioni sono una testimonianza di come gli “oggetti culturali” viaggino da una parte all’altra del mondo, e di come, in questa trasposizione, diventino più ricchi. Questo avveniva ben prima delle nostre enfasi inter-mono-culturali. L’episodio di Akbar mette in evidenza un dato da tenere per fermo: ciò che noi consideriamo “intercultura” non è l’affermazione di un eccezionalità, ma – al contrario – è la forte sottolineatura che chi ne sostiene le ragioni non fa altro che sostenere quelle della cultura umana, tour court.
La lezione di Akbar
Ma a questo punto: chi era Akbar? Il suo nome per intero era Jalaluddin Muhammad, terzo imperatore della dinastia Moghul, i conquistatori musulmani della penisola indiana. Akbar, “Il più grande”, fu il nome che si attribuì, non temendo di fregiarsi dell’appellativo che i musulmani riservano a Dio. Regnò a lungo, una cinquantina d’anni (1542-1605), completando le conquiste dei suoi predecessori e consolidando il suo dominio con una organizzazione politica e amministrativa che durò secoli, fino all’aggressione inglese del 1858.
Il suo interesse per le religioni era vivissimo, come abbiamo visto. Conoscerlo ci aiuta a conservare la nostra barra, diritta sulla consapevolezza critica dei fatti umani.
Akbar eresse nel 1575 una “casa del culto” (ibadatkhana), nella sua nuova capitale, Fathpur Sikri, nella regione dell’Uttar Pradesh. In questo edificio raccolse testi, immagini e sapienti di ogni religione. Qui fece convenire mullah e imam delle varie confessioni islamiche, santi di tutta l’India e, infine, i recentissimi e nuovi gesuiti. Voleva che si confrontassero, che cercassero insieme un dio che li mettesse tutti d’accordo. Un’impresa per niente agevole. Si racconta che più volte dovette fare la voce grossa, soprattutto a causa delle liti fra musulmani, o delle intemperanze dei gesuiti, che alla vista dei seguaci di Muhammad, perdevano ogni ritegno. Alla fine, probabilmente spazientito, decise di inventarsela lui la religione universale e pacificatrice. Una religione strana, senza teologia né culti, che spingeva alla generosità personale, alla cura del bene comune, aperta all’ambiente e alla natura. O una “setta”, come dissero immediatamente i suoi detrattori. Akbar non sembra, infatti, aver avuto vita facile come inventore di religioni, nonostante il suo immenso potere. Considerato eretico o apostata dai musulmani, pagano dai cattolici, miscredente dagli indiani, materialista un po’ da tutti, suscitò – se mai ce ne fosse stato bisogno – gli aspetti di intolleranza delle religioni allora esistenti. A conti fatti, la sua politica religiosa servì a costruire intorno alla sua dinastia un’aura di sacralità, che ne circondò per secoli il potere, fino appunto alla dominazione inglese.
Un destino che lo fa assomigliare (fatte salve tutte le differenze) a quei pacificatori politici che, in nome di una qualche unità, fondano un partito che dovrebbe accogliere tutti. L’unità non si raggiunge, ma il panorama politico, di solito, si arricchisce di un nuovo venuto.
Per saperne di più, vai a vedere la mostra alla Fondazione Roma Museo, Palazzo Sciarra, dal 23 ottobre al 3 febbraio 2013 (http://www.fondazioneromamuseo.it/it/840.html ), oppure leggi il catalogo, a cura di Gian Carlo Calza (a cura di), Akbar. Il grande imperatore dell’India, Skira, 2012.




















